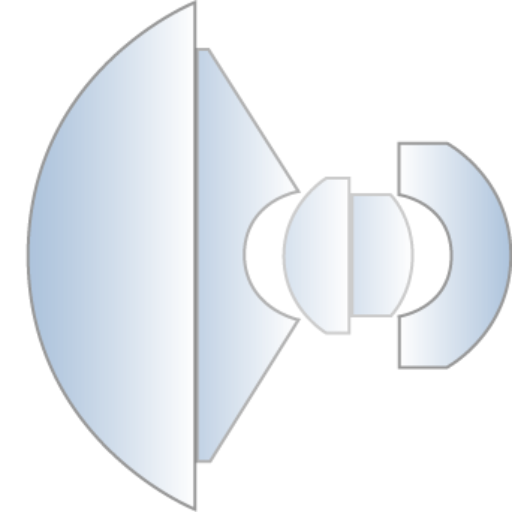28 dicembre 2017
STORIA DI UN VIAGGIO
Ho sempre saputo d’essere alla ricerca di qualcosa, di un perché.
Un grigio impasto di terra, granuli di materia fatta di microscopiche forme viventi.
Non ha nome. Nessun nome. Silenzio. Un vento gelido ghiaccia la terra. In alto, squarci di luce abbacinante. Lampi. Boati. Il fragore dei tuoni fa tremare le ombre di alte conifere. La foresta di felci arboree è attraversata da folate rabbiose che tagliano la pelle nuda dell’ominide. ———————————————————
La vasta pianura è calda e luminosa. In lontananza, dune di sabbia ed arbusti brulli. Strane forme viventi corrono sfiorando la terra rossa. Non hanno nomi. Solo forme, colori, rumori, odori. Lo stupore cede al dolore ogni attenzione. Dentro qualcosa stringe i visceri come in una morsa. Lui tende la mano ad un cespuglioso dal quale pendono frutti nerastri. Strappa le bacche e le porta alla bocca, cibandosene voracemente fino a esserne sazio. Lo vedo con chiarezza. Lui sente il mio odore e mi cerca con lo sguardo pavido. Forzando sulle braccia, dalla posizione prona mi ergo in piedi. Lui mi vede e arretra con fare goffo, tuttavia senza girarsi, né darsi alla fuga. Sembra incuriosito. Muove le grosse narici scimmiesche per annusare il mio odore e inarca le sopracciglia con una smorfia che mi pare simpatica. Sorrido allungando il braccio destro, ma lui arretra ancora e si nasconde dietro una felce. Poi sale sull’albero con grande destrezza, come un acrobata o come uno scimpanzé. Perché non ho paura di lui? D’un tratto, emette una specie di richiamo gutturale, come un vocalizzo poco articolato. Adesso ho paura.
Apro gli occhi. La penombra della stanza mi è familiare. Il grosso orologio manda una luce verde che illumina debolmente gli oggetti come un ricordo costante. Posso scorgere ogni cosa. Dietro la porta alla mia sinistra sento il suono di passi felpati e qualche bisbiglio indistinto.
La strada è deserta. Deve essere l’alba. Il basolato è umido, scivoloso. Dove mi trovo? Una donna porta una grossa anfora ansata di terracotta. Mi passa accanto senza dar conto della mia presenza. A pochi passi c’è una vasca con una fonte. Alza un poco la veste per non farla bagnare nelle pozze per terra; sale un piccolo gradino di pietra. Si sporge sulla vasca e riempie l’anfora d’acqua, che, infine, mette sotto il braccio destro, facendola poggiare sull’anca. Ha i piedi scalzi, una crocchia di capelli neri tenuta ferma da un pettine di legno. La veste è di tela, come una specie di lenzuolo annodato sulla spalla e stretto in vita da una striscia di tessuto grigiastro, con una semplice fibbia di metallo. Adesso il Sole manda dei raggi rosacei e caldi come tenui carezze. La ragazza alza un po la testa e tiene gli occhi socchiusi. Sorride. La vedo bene adesso. Mi pare molto bella, ma soprattutto molto dolce, amichevole. Mi giro di scatto, e la vedo allontanarsi con il suo carico d’acqua. Scompare in un ingresso senza uscio, coperto in parte da un drappo sdrucito. La seguo con lo sguardo, poi d’un tratto scosto il tendaggio ed entro. Dov’è andata? Passato il varco, mi si apre dinanzi un locale scoperto, come un piccolo cortile dal pavimento in terra battuta, circondato da alte pareti intonacate, color rosso-mattone. Un vento caldo mi costringe a voltarmi. La tenda è sparita. Davanti ai miei occhi si apre una savana arrossata dal Sole che si alza all’orizzonte. Due antilopi, brucano l’erba gialla. Si fermano all’unisono alzando la testa, quindi cominciano a correre. Mi accorgo solo ora che una leonessa era in agguato ed ora le insegue poco convinta: hanno troppo vantaggio! La fiera si ferma. Poi guarda dalla mia parte. E’ a cento, forse centocinquanta metri da me. Adesso è ferma e mi guarda. Una mano ossuta mi stringe la spalla. Mi volto di scatto. L’ominide mi invita a seguirlo, stando a quattro zampe. Poco distante ci sono due alberi dall’ampia chioma. Sale agile arrampicandosi lungo il tronco, sino a raggiungere i rami più bassi, a circa tre metri. Io lo seguo a fatica, graffiandomi le braccia e le gambe. Mi accorgo solo ora di indossare una sorta camicia di tela, forse di lino. Sono scalzo e i piedi cominciano a sanguinare. _____________________________________
Da dove arriva quel tipo con la chitarra? Ha una sedia di paglia come non ne vedevo da anni. Cosa sta suonando? Tra le corde, in alto sul manico ha infilato uno di quei bastoncini forse d’incenso, acceso, che manda un debole fumo odoroso. Il giovane uomo dai capelli lunghi, ha la barba e somiglia un po ad un Cristo nervoso, forse un po ad un autoritratto di Durer. Inala l’odore d’incenso e ne sembra come inebriato. Suona freneticamente con uno stile virtuosistico, facendo strane smorfie e vocalizzando sommessamente come Glen Gould nelle variazioni Goldberg. Mi accorgo che si tratta di una specie di salmodia accompagnata da un suono d’arpa. Vedo le mani affusolate muoversi agili sulle corde doppie e nel controluce una bella testa di donna che china il capo delicatamente da un lato. Durer è svanito nel nulla, adesso è una donna che suona l’arpa! Mi sento chiamare. Mi volto rapido riconoscendo la voce, ma una volta girato vedo il suonatore di chitarra che mi offre una coppa, tendendo il braccio verso di me. Allungo un braccio a mia volta per afferrare la coppa di metallo, bella come un calice. Si tratta di un calice ornato di gemme ricolmo di vino, rosso come sangue, che emana riflessi argentei, ammalianti come sorrisi. Lo porto alle labbra e bevo, socchiudendo gli occhi, quando, d’un tratto, sento nitrire e, al riaprirli, dinanzi a me il suonatore monta un bel destriero bianco, grande, maestoso, dalla criniera grigiastra. Il suonatore ha un liuto a tracolla e indossa una bella tunica azzurra con bordi dorati e una berretta di panno chiaro con un buffo con con che scende di lato, che gli da un aspetto da menestrello. I lunghi capelli d’un chiaro castano, scendono copiosi in lunghi boccoli da fanciullo. Difatti, non ha la barba come aveva prima, ma vedo una peluria chiara da adolescente. Scende dal cavallo con un balzo leggero. Ha strane calzature. In effetti è abbigliato come uno di quei trovieri occitani che tanto ho amato da giovane e adesso me lo vedo davanti e brandisce il suo grosso liuto e prende a suonare una melodia triiistissima, come una sorta di lamento. Il giovane prende a parlare, con voce monotona, come avesse una visione e dice di chiamarsi Bernardo e di amare una donna bella e gentilissima, la signora sposa del Gran Conte di Normandia e d’essere teneramente ricambiato e che la donna è stata rinchiusa in un convento e lui esiliato per questo loro amore illecito e comincia a piangere mentre i suoi occhi e la bocca esprimono un sorriso languidissimo che mi commuove ed io piango con lui e mi sovvengono immagini che credevo sepolte di fanciulle dai luoghi capelli sciolti nel sole come le figure della Primavera di Botticelli. E dice di se d’essere figlio d’un servo di palazzo, e che egli era stato educato per far da menestrello e allietare le ore dei nobili signori e delle belle dame, ma che la sua colpa lo aveva fatto cadere in disgrazia e solo la sua arte e la benevolenza del signore lo aveva salvato dalla punizione più estrema. Mi accorgo adesso che Bernardo guarda verso una bassa altura dove s’erge maestosa una grande quercia grigiastra e dietro il tronco scorgo una chioma di riccioli dorati che rapida si nasconde alla mia vista e a quella del cantore.
Un vapore odoroso si leva appannando il cristallo degli occhi. Adesso. Adesso è quiete. Ora che gli anni hanno reso più mite lo sguardo, un tempo vago e febbrile. Un tempo tanto irrequieto. Tanto, che ora appare un estraneo, come un racconto d’altri tempi cui non si è mai pensato come reale. Qual’è il progetto che assilla la mente? Vedo dei disegni, come cartoni d’un affresco. Bozzetti, accenni di linee e chiaroscuri a penna. Personaggi abbozzati emergono dal pallore del foglio e protendono le braccia verso l’alto come nella Zattera della Medusa. Un uomo di media statura, si avvicina corrucciato al tavolo. Indossa una larga camicia senza polsini e una sciarpa leggera, biancastre e opache, come una tela, forse di lino. Piccole finestre tonde e strombate, molto alte sulla parete destra, rischiarano di luce diffusa l’ambiente, lasciando in penombra il pavimento e tutta la zona in basso. La grande aula è coperta da una volta a botte e le pareti giallognole sono striate di fuliggine. Qui e la, maestose ragnatele. Mi pare come una sagrestia. Anche la mobilia. Le madie lungo la parete sinistra, di legno scuro e intarsiato, sono quelle di antiche sagrestie seicentesche. L’uomo si china sulle carte poggiando i pugni sul tavolo, poi con la destra prende uno dei fogli e lo volge in direzione della debole luce facendo quasi una torsione. Lo osserva pensoso e il suo volto dai lineamenti duri assume espressioni indefinibili. Mi avvicino con una sorta di inchino, come si faceva un tempo, stando un po curvo col cappello in mano. L’uomo si gira improvvisamente e volgendosi verso la porta dalla quale era entrato grida: – porta del vino e un candeliere, svelto! – Da quella stessa porta, dopo pochi istanti entra un ragazzo di quindici anni o poco più. Poggia il vassoio di metallo sulla madia e resta in attesa, col candeliere in mano. Lo osservo attentamente. Ha una folta chioma corvina di capelli scarmigliati e lunghi. Indossa una casacca senza colletto, una singolare sorta di pantaloni come alla zuava, stretti sotto le ginocchia, di panno marrone, calze grigiastre e un paio di zoccoli bassi con la fascia di cuoio inchiodata, malandati e troppo grandi per i suoi piedi. Il ragazzo sembra impaziente. Si guarda intorno e ad un tratto fissa l’attenzione verso un punto preciso della stanza e accenna un sorriso. Guardo a mia volta dalla stessa parte e mi accorgo che dalla base della madia, un topo fa capolino. In terra vi sono briciole di pane. Nella penombra del pavimento appena rischiarata dal candeliere, vedo il sudiciume accumulato negli angoli e un po ovunque. Il padrone fa un cenno col braccio senza voltarsi che il ragazzo interpreta prontamente. Poggia il candeliere accanto al vassoio e poi sia avvia verso l’uscio, non senza prima aver lanciato un’atra occhiata al topo, che intanto era uscito per arraffare un piccolo tozzo di pane con le sue zampette minute.
A questo punto mi è chiaro che per ognuno di queste persone sono come un fantasma. Invisibile, inudibile, intoccabile. Non si accorgono di me.
Io sono lì, non è un sogno, non un incubo della ragione, forse un delirio? I ricordi si fanno immagini ed esse si materializzano davanti ai miei occhi in ambienti, personaggi, azioni, dialoghi. Approfitto della situazione per avvicinarmi al tavolo di lavoro dove il padrone di casa sta osservando a lume di candela le sue carte giallognole. Sono veloci schizzi a sanguigna, segni vorticosi di chiaroscuro, corpi, fisionomie grottesche, pose improbabili di muscoli forzati dalla crudele mano d’un virtuoso. Grugnisce forse disapprovando, quindi fruga tra le carte, infine trova ciò che cercava e atteggia le labbra in una smorfia, stavolta compiaciuta. Avvicina il foglio alla fiamma ed io vedo controluce un disegno quadrettato. Una Deposizione dalla Croce. E’ il Pontormo!
Intanto che il mio stupore mi fa quasi barcollare da dovermi poggiare al tavolo, bussano alla porta. Il ragazzo di prima fa capolino e annuncia la visita di mastro Guglielmo e del suo allievo Niccolò, un giovane bruno di capelli, vestito frugalmente in abiti da lavoro. Guglielmo è un uomo sulla cinquantina che parla a voce bassa, con un accento francese che si nota a tratti tra le cadenze toscane. Da quello che dicono, capisco che parlano del lavoro in una cappella gentilizia, nel quale il maestro più anziano deve creare delle vetrate dipinte con scene della vita di Cristo. Guglielmo ha con se un tubo di cuoio marrone dal quale estrae un rotolo di carta. Srotola alcuni fogli con dei disegni precisi, quasi geometrici che rappresentano dei finestroni suddivisi in riquadri, con scene popolate di personaggi in pose teatrali.
Buio.
Rumore di passi nel buio. Un vociare sommesso, furtivo. Un grande sipario si apre con fragore tenebroso. Le voci si fanno più chiare, odo un forte No! Come un tuono, poi di nuovo il silenzio. Chi sono costoro?
Maestro, vi prego, siate ragionevole. L’uomo cui si rivolgono i questuanti è di piccola statura, nervoso, col volto scarnificato è un cipiglio che incute soggezione. No! Ripete brusco.
È un giorno qualunque dei tanti già vissuti. Eppure questa visione mi è nuova. Sono qui in un presente fatto di cose, di spazio, di suoni e odori. Il gatto sale sulla tavola. Il cane sta abbaiando alle campane. E vedo, vedo qualcosa che non appartiene al presente, eppure è presente. Presente come i suoni e gli odori e il gatto e l’abbaiare del cane. Quella donna la conosco bene. Come potrebbe altrimenti? La vedo così chiaramente. Quella donna è mia madre. Avrà la metà dei miei anni a quel bambino che porta in braccio, deve essere il me che fui a pochi mesi.
La donna si alza dalla sedia di paglia su cui era seduta e depone delicatamente il bambino in una piccola culla di vimini, accomodandogli addosso una sottile coperta chiara di cotone. Il bimbo si è addormentato. Ha un’espressione beata che trasmette anche dintorno là serenità che deve certamente provare nel suo animo immaturo. Affatto inesperto del mondo.
Quando tutto ebbe inizio.
Tutto ha avuto inizio con le luci e suono di voci indistinte. Lo sgomento della vita, ora, in questo tempo reale riempito di luci e suono di voci indistinte, è il mio tempo. Da questo momento, in questo universo minimo, io sono e voi siete, per me, ciò che vedo, che sento, che amo, che odio.
Un uomo. Ha uno strano cappello di paglia di foggia orientale, come da contadino del Guangdong. È magro e porta occhiali tondi. Ha in mano un vecchio libro che porta sulla copertina delle lettere a caratteri gotici. Cammina con passo lento. Alle sue spalle c’è una casetta che sembra una baita di montagna, davanti a lui, un sentiero che si perde tra alti alberi e s’inoltra nel bosco. ——————————————————————————
In questo piccolo mondo dominato da un dio potente ed incerto, i nembi di piombo corrono veloci e riempiono il petto di sgomento. ——————————————————
Guido Durante non vi appare uomo da far salotto. Nel condominio dove viveva a stento salutava qualcuno. Non che avesse particolari antipatie e solo che non gli andava. Io sono Anselmo, uno dei pochi amici che ancora gli resta. Per chi non lo conosce, Guido è un enigma. Parlando con uno – uno di quelli che appunto, buongiorno e buonasera – mi fa: ma tu sei amico di quel tale Durante che abita al 12? È che sembra uno capace di qualunque cosa. S’era sparsa la voce che Guido odiasse il mondo intero.
Voi Costruttori di città. Distruttori di città e di interi mondi. Avete visto i roghi degli incendi. La fornace ha divorato intere foreste. Il ferro lo avete ben forgiato. Il ferro strappato alla terra lo avete mutato in sangue. La punta aguzza. La lama affilata, più forte della pietra ha mietuto vite come gli steli di grano. Demetra, ha ceduto il passo ad Ares.
Avete visto il Vulcano rombare e lanciare magma di terra rovente oltre le nubi. Avete visto il terrore mozzare il fiato al vostro orgoglio. Quel terrore che accompagnava i passi del nemico ora vi cammina accanto. Un dio potente vi è ora nemico. La terra. La terra si scuote e si gratta come un botolo gratta via i parassiti che lo molestano. Il mare. L’acqua salata che non v’appartiene, risale lentamente. Ingrossata dalle lacrime e dal piscio. Ora. L’ora è tarda!
Il lavoro che c’è da fare è quello che non si farà.
Dietro la maschera. Nel fondo oscuro di quel pozzo profondo si cela non un mistero… Non vi è nulla di mistico o di misterico. Le nostre parole, tutte le nostre maledette parole; le sublimi, le preziose, le potenti, superbe, irripetibili parole, con le quali abbiamo fatto a pezzi ogni cosa e l’abbiamo fagocitata… non conta nulla. È nulla e non ne resterà niente. Il lavoro che c’è da fare nessuno è disposto a farlo. È un lavoro sporco. C’è da sporcarsene le mani. Scavare, scavare, levando il fango e i detriti che coprono pietosamente la miseria di un corpo malato. La solitudine, il rancore che cova ogni infame, ogni miserabile fuscello esposto alla più tenue brezza… … … abbandonarsi, non far resistenza. Sentire il sangue pulsare, il desiderio, la brama del possesso, la cupidigia laida, accaldata e sudaticcia che lascia il bruto sazio ed appagato… lascia l’angelo svuotato e depresso. L’angelo che non sa ancora di esser tale.
Eppure c’è in lui della grandezza. C’è una fiamma che fa spendere di riflessi radiosi il cristallo dello sguardo. Qualcosa che sa illuminare e riscaldare. Questo è il misero bruto che ha conquistato la posizione eretta e s’è incamminato per il sentiero impervio. La perdita dell’innocenza è la strada per riconquistare una innocenza più elevata. L’innocenza di chi è consapevole.