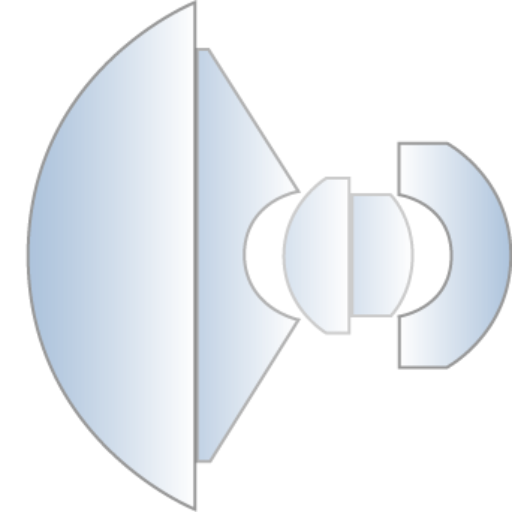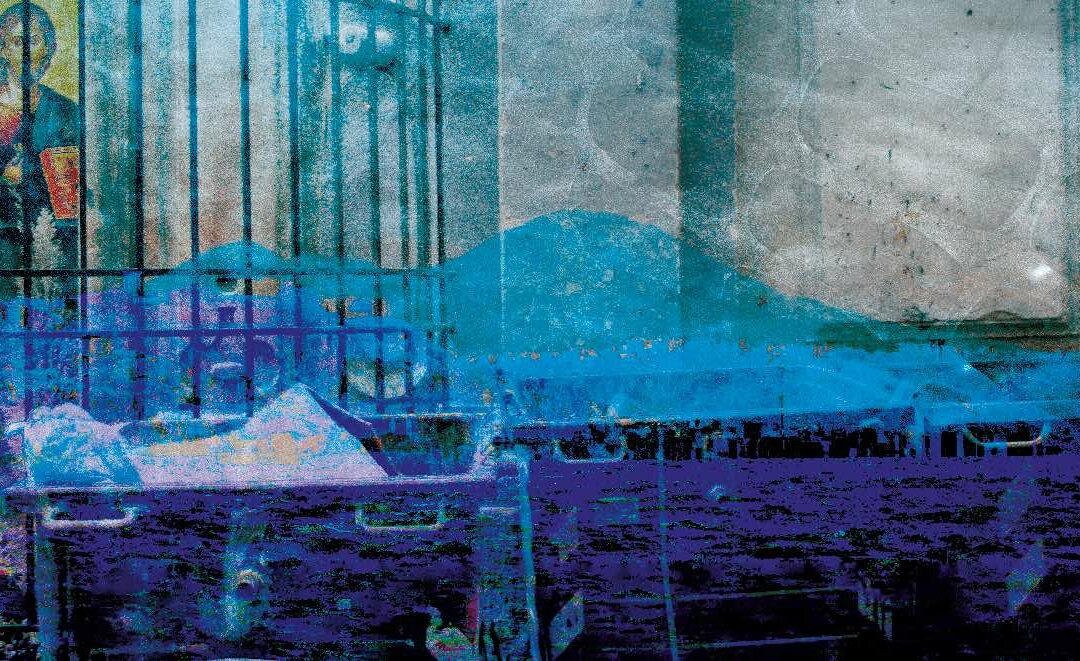Ogni opera diremo qui “visiva”, che non sia mero commercio, che sia cioè intimamente ingerita nell’esistente, rappresenta un cammino di conoscenza. Non necessariamente rettilineo. Involuto talvolta, controverso… Una fatica che esalta ogni istante, colmandolo di valore. Non dico di senso, ché questo è dominio del sacro e in quanto tale, sarebbe, dovrebbe essere il traguardo del cammino medesimo… La materia, investita dalla fatica del fare, dalla volontà dell’esistente, acquista valore, pregnanza e dunque sacralità. Ecco il senso, in nuce, che chiede d’essere svelato!
Non ha corso ivi la domanda d’un senso compiuto, perfettamente rivelato come un credo, una dottrina. Non vi sarebbe il cammino di ricerca, fatto di piccoli passi, di tanti insidiosi scandali alla disciplina del fare. In se stessa l’opera – ognuna e d’ogni genere – trova il suo senso minimo e bastevole, che basta a illuminare il passo, se vi riesce, che conduce al successivo. E questa sedimentazione, questo accumulo di micro-senso che dirada un poco, e non mai dissipa del tutto, la nebbia del caos, dell’ignoranza e della morte.
In questo tempo triste, figlio di tempi tristi, arte è opera e opera è mercato. Una cosa che si vende e si compra. Linguaggi e tecniche che si imparano nelle scuole e nelle università, posti al servizio della comunicazione, funzionali alla trasmissione di messaggi. Vi sono quelli che conoscono e praticano quelle tecniche e usano quei linguaggi e quelli che fruiscono delle loro opere; quelli che in un modo o nell’altro, le acquistano. Non è per questo che si fece arte. L’equivoco nasce dal fatto che arte ed esistente si sono dissociati. Arte è ora linguaggio, tecnica, opera. Ma essa fu necessità, sacralità, preghiera, gratuità, dono. Poi divenne ornamento, monumento, prestigio dei potenti, emblema di potere. Ancora, in certo senso, condizionata dalla originaria sacralità. Poi le opere divennero sempre più oggetti, preziosi, prestigiosi; infine merce.
Si può obiettare che l’opera abbia senso principalmente in quanto merce, oggetto di scambio economico e dunque in quanto prodotto. Ma in quanto tale, la osserviamo al termine del processo e la consideriamo prescindendo da esso, ignorandone la natura, disconoscendone o misconoscendo il gesto, la necessità che l’ha originata e che unicamente hanno importanza per chi l’ha creata. Qui si può obiettare che questo è precisamente lo scopo della critica, il ruolo del critico. Andare ad indagare l’esistente in relazione alla sua opera. Una sorta di “mediazione culturale” che diventa utile nel quadro economico. Plausibilmente, in un rapporto personale tra critico e artista, essa può favorire la comprensione reciproca laddove il primo possiede gli strumenti analitici della filosofia estetica e il secondo essendo portatore di un vissuto che nelle sue opere si esprime.
Non importa ciò che l’arte è per il mercato e per la critica. Qui, quello che interessa è ciò che l’arte è in se, ovvero come risultato di un processo che diremo “creativo”. Quello che intendiamo sostenere è che non già l’opera come oggetto, prodotto, merce o altro sia importante; quanto piuttosto e sostanzialmente “l’atto creativo” e non già perché all’origine delle opere, ma come percorso che interroga, indaga un territorio dello spirito non altrimenti accessibile e comunque difficilmente accessibile.